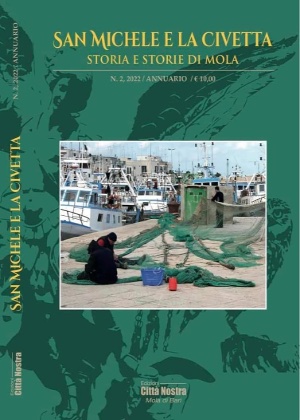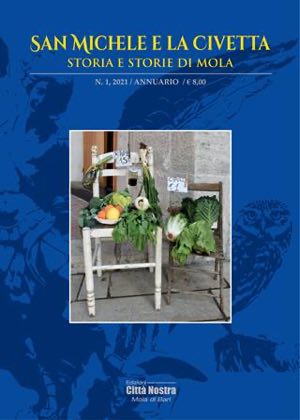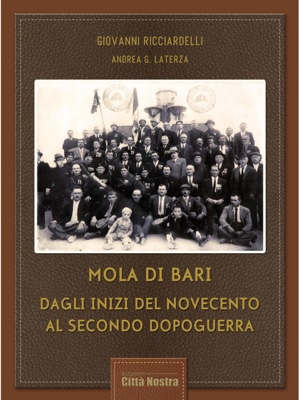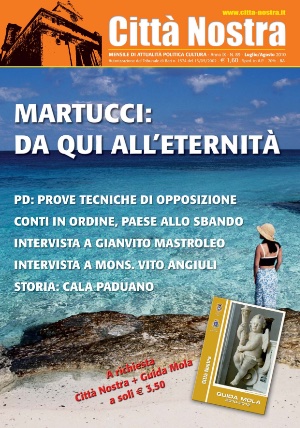di Giovanni Miccolis
(Prima parte)
Un clero a Mola esisteva molto tempo prima della rifondazione angioina del 1277, religiosi impegnati nelle cappelle delle ville dell’agro molese e nell’antica chiesa del borgo, che il Garruba riteneva fosse stata “edificata poco dopo che Costantino diede la pace al Cristianesimo”, in pratica nel quarto secolo d. C.
 All’inizio dell’anno mille esisteva, in ogni caso, un clero organizzato e dipendente dall’arcivescovo di Bari, così come attesta il documento del 1171 riportato dal De Santis nel suo libro, documento dal quale si evince che il clero di Mola era ammesso alle funzioni delle festività dell’Assunta nel turno del 18 agosto, unitamente a quello di Santeramo, Sannicandro e Binetto.
All’inizio dell’anno mille esisteva, in ogni caso, un clero organizzato e dipendente dall’arcivescovo di Bari, così come attesta il documento del 1171 riportato dal De Santis nel suo libro, documento dal quale si evince che il clero di Mola era ammesso alle funzioni delle festività dell’Assunta nel turno del 18 agosto, unitamente a quello di Santeramo, Sannicandro e Binetto.
Garruba peraltro sosteneva che Mola «Per isvista del tipografo fu omessa nello Statuto di Rainaldo [1171-1188]… ma non è men vero di esservi stata menzionata, come può ricavarsi dal Sinodo diocesano dell’ Arcivescovo Caracciolo, e dal Lombardi nella vita dello stesso Prelato… Mola fu anche menzionata nella Bolla di Alessandro III [1159-1181]… dal che evidentemente ricavasi che fin da tempi antichi quella città fece parte di quest’Archidiocesi, come poi 1’ha fatto in prosieguo ed insino al presente» – (Michele Garruba, Serie Critica de’ Sacri Pastori Baresi- Bari, 1844 – pag.851).
Con la rifondata del 1277 Mola era un piccolo borgo popolato da circa 150 famiglie poverissime, con gli abitanti dediti alla coltura di terreni rimasti incolti da secoli; mancavano altre attività produttive, compresa la pesca per la mancanza di barche.
Subito dopo la partenza nel 1350 degli invasori ungheresi, cominciò un periodo di relativa tranquillità che permise lo sviluppo delle attività produttive relative all’agricoltura ed alla pesca.
Finalmente nelle campagne era possibile incontrare estensioni di terreni con alberi di olivo di mandorlo e di carrubo, colture di ortaggi, campi di grano orzo e avena. Notevole era anche la pastorizia con 1.500 capi di grosso bestiame e 18.000 di bestiame minuto.
Si svilupparono, inoltre, i trasporti via mare verso altri porti «intra regnum» (Vieste, Trani, Bari, Monopoli, Otranto) ed «extra regnum» (Serenissima Repubblica di Venezia e le città dalmate di Ragusa, Cattaro, Antivari e Dulcigno). Le «tratte», in altre parole i prodotti esportati, riguardavano soprattutto olio, frumento, orzo, ceci, fave. Alcune famiglie molesi, con i notevoli guadagni provenienti dal commercio dei prodotti esportati, divennero ben presto ricche; i loro cognomi risultano dai documenti di viaggio: Berlingerio, Colletta, Caczuolo, Colonna, Giannotto, Greco, Lionello, Lucortho, Marinello, ecc.
Con l’aumento della popolazione e l’accresciuto benessere si ebbe anche un potenziamento del clero per soddisfare le notevoli esigenze spirituali, soprattutto dei nuovi benestanti.
Prelati molesi ricoprirono cariche importanti in altre città. E’ il caso di Roberto, arciprete di Rutigliano nel 1416.
Signore e barone di Mola era Landolfo IV Maramaldo. Suo figlio primogenito Antonio gli premorì e la vedova Masina della Marra nel 1456 gli intentava giudizio per restituzione della dote.
Nel resoconto dei diplomatici Anselmo Adorno, partito da Bruges, e di suo figlio Giovanni, Mola fu così rappresentata: «E’ un piccolo borgo, cinto da forti mura, con una piccola fortezza. Le case sono alquanto scarse. In questo luogo sono molto più numerose le donne, tant’è che ci sono quattro donne per ogni uomo» (“Mola parvum est oppidum, circumcirca fortibus muris cinctum, habens parvum fortalicium. Domus satis exiguae sunt. Eo in loco femellae multo plures sunt viris, ita quod quattuor sunt feminae respectu unius viri” – da Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte [1470-1471]). Era evidente il fatto che mancavano tanti mariti partiti con le loro imbarcazioni in viaggi che duravano diversi giorni!
Erano ancora presenti le forti mura angioine ed una piccola fortezza che, molto probabilmente, era all’esterno delle stesse mura, nucleo del castello rielaborato da Evangelista Menga tra il 1535 ed il 1540, in pratica dopo la partenza dei Veneziani.
L’unica chiesa pubblica era la Matrice che, nonostante i numerosi lasciti e donazioni, era un edificio malandato, con notevoli guasti. Il fatto non poteva certo attribuirsi ai Veneziani che avevano molto rispetto per i luoghi religiosi e forse neanche agli abitanti del castello che sparavano sul borgo con i loro cannoni (l’evento sarebbe stato riportato in qualche documento).
Non è escluso che lesioni alla chiesa furono procurate dal famoso terremoto del 1456, anche se nelle relazioni dell’epoca non furono riscontrati danni a Mola («Maola, Barium…Horum terremotuum vehementiam audiverunt, sed nullum exinde detrimentum susceperunt»). Si avvertì una forte scossa, ma non si ebbero danni evidenti. E’ possibile tuttavia che lesioni occulte procurarono danni negli anni successivi.
Nel 1542 si ebbe la visita pastorale dell’arcivescovo di Bari mons. Girolamo Sauli, il quale ritenne la chiesa pubblica di Mola una spelonca di ladri (spelunca latronum quam ecclesia).
Eppure i benefattori non mancavano: Pietro de Mietolo, con il testamento del 19 ottobre 1528, lasciava parte dei suoi beni per una cappella da edificare nella Matrice, da dedicare alla Madonna della Neve (lo stesso aveva già donato il suolo per edificare il convento e la chiesa di Santa Maria del Passo); Battaglino de Mola, con altro testamento del 15 novembre 1530, dispose per un altare dedicato a San Rocco; tanti altri deliberarono per lasciti inferiori.
Sulla scia delle numerose istanze di riordino dell’attività pastorale che portarono al Concilio di Trento, il vicario dell’arcivescovo barese, mons. Girolamo Zacconi, eseguì in Mola ulteriore visita episcopale dal 28 settembre 1545. Questi attuò una meticolosa indagine in tutta la terra di Mola per giudicare, punire e correggere (“punienda et corrigenda”).
Grazie a Dio (“Ideo Deo gratias egimus!”), il prelato ritenne innanzi tutto che i “sacramentum sacramentorum eucharistie” erano custoditi in modo dignitoso, una custodia in ogni caso precaria, perchè la chiesa era quasi in rovina e necessitava urgentemente di restauri.
Diversamente, il vescovo non ritenne conformi l’aspetto ed il comportamento dei chierici, ai quali ordinò di adeguarsi alle prescrizioni nel termine di un mese (“hoc spatio unius mensis a presenti die numerando”).
Reputò scandaloso il fatto che molti laici contraevano matrimonio verbalmente senza la benedizione del sacerdote (“Reperimus etiam multos laicos contraxisse matrimonium per verba de presenti et diu mansisse et manere cum suis uxoribus non habita sacerdotale benedictione”).
Si soffermò sulle unioni coniugali vergognose ed immorali, come quella di Sebastiano della Volpe, che si era congiunto verbalmente in seconde nozze con donna affine di secondo grado (“Sebastianum della Volpe contraxisse matrimonium per verba de presenti cum Ricca secunda uxore in secundo gradu affinitatis, et diu mansisse, et in presentiarum manere cum ea et ex eadem multos filios procreasse, nulla obtenta appariter dispensationem, et sic in peccato mortali mansisse et manere in grave preiuditium et pernitiem animarun suarum”).
Manchevolezze gravi riscontrò anche nell’attività patrimoniale; ed, infatti, il clero risultò negligente nell’esigere i “legati” (lasciti) dei fedeli (“negligentem in exigendis dictis Legatis”).
L’esame riguardò anche le chiese private, questa volta con soddisfazione e compiacimento: la chiesa di San Giuliano del beneficiario Nicola de Girardo; la chiesa di Santa Maria Annunziata del beneficiario Francesco de Valeriano; la chiesa di San Sebastiano del beneficiario Antonio Giovanni de Mariella; la chiesa di Santa Maria di Loreto, con annesso ospedale, del beneficiario Sabinello de’ Sabinellis (quest’ultimo fu invitato a conferire la cappella alla Matrice per meglio onorare la SS. Vergine; invito raccolto dal figlio Giovanni il 21 maggio 1587).
Dopo la Matrice, la chiesa più antica in cui era possibile seguire la messa era quella dell’Annunziata, istituita con testamento del 24 giugno 1399. La Maddalena, all’inizio del 500, era una “cappelluccia” nella quale non si celebrava più messa; soltanto il 25 agosto 1617 i primiceri don Stefano Mutassi e don Rocco d’Amico decisero per la costruzione di una chiesa “per comodità delle zitelle e di altri fedeli a cui, per ragione di età o di salute, era malagevole recarsi dentro la Terra”. La chiesa di san Domenico fu costruita nella prima metà del 1500 ad iniziativa dell’ordine dei Domenicani.
Per quanto riguarda la Matrice mons. Zacconi ordinò che si iniziassero i restauri entro otto giorni e che l’opera fosse compiuta in 3 anni (“infra terminum dierum octo… reparationem ipsius ecclesie inchoasse habeant… infra terminum trium annorum a dicto… integre funditus et radicitus reparasse refecisse et construxisse…”- Archivio Capitolare, vol. VI).
Arciprete del tempo era Cristoforo Pietanza, nominato nel 1541, il quale interessò tutto il clero, gli amministratori dell’Università ed i “galantuomini” per esaminare come realizzare l’incarico, con quali maestranze e quali mezzi finanziari.
Molto probabilmente non fu rivolta alcuna istanza alla feudataria di Mola Brianna Carafa, vedova di Vincenzo Toraldo, che aveva impegnato tutte le sue sostanze per abbellire il castello, luogo dove si tenevano sontuose feste e durante le quali ammiratori ed amanti circondavano una delle donne più belle del Regno. Il poeta di Barletta, Mario Di Leo (1514- 1548) descrisse il suo fascino e la sua avvenenza nell’opera L’Amor Prigioniero. Anche il letterato di Modugno, Amedeo Cornale, poeta preferito da Isabella d’Aragona, volle dedicarle un sonetto (Non mortal donna ma celeste Dea).
I molesi ritennero, dopo ponderata analisi, che conveniva rifare completamente il tempio per adattarlo alle esigenze dell’accresciuta popolazione.
Nonostante il grande impegno profuso, soltanto nel 1575 i lavori di ricostruzione furono completati.
La Chiesa di Mola, dedicata a san Nicola di Bari e sotto la protezione di san Michele e san Giovanni Battista, era riconosciuta “Collegiata Insigne quoad honores” sin dalla sua nascita, titolo riconfermato dalla Santa Sede nel 1582, dalla Nunziatura di Napoli nel 1669, dalla Real Camera di santa Chiara con due consulte del 1782 e 1783. Mancando la “prova” del titolo di erezione in collegiata, Ferdinando IV intervenne con decreto del giugno 1790 per stabilire che la chiesa rimanesse collegiata “quoad honores” (di puro titolo).
La Collegiata di Mola fu “ricettizia innumerata” fino al momento in cui il capitolo non deliberò di fissare, per una più dignitosa divisione delle rendite, a venticinque il numero dei partecipanti. Con conclusione capitolare del 13 ottobre 1613 furono eletti due rappresentanti per la redazione degli statuti che avrebbero segnato il passaggio a “ricettizia numerata”. La Curia Arcivescovile, con decreto del 7 giugno 1614, ordinò – su delega di Papa Paolo V, conferita con breve del 12 marzo 1614 – che fosse mantenuto in venticinque il numero dei partecipanti al clero e al capitolo di Mola e che a quelli fossero riservati gli stalli superiori del coro.
A Cristoforo Pietanza seguirono gli arcipreti: Tommaso Depertis (1551-1561), Francesco Susca (1561-1581), Gerardo de’ Gerardis (1581-1585), Angelo d’Amico (1585-1610), Oronzo Susca (1610-1627), Angelo Antonio Zuccarino (1627-1680).
Il Capitolo aveva notevole prestigio e fu spesso protagonista nelle vicende che contrapponevano l’Università al feudatario.
Durante la terribile peste che decimò la popolazione molese negli anni 1690-1692, arciprete era Giuseppe Zuccarino (1680-1725) e ben 36 sacerdoti persero la vita nell’assistere i ricoverati del lazzaretto.
Gran parte dell’archivio fu distrutto per evitare il diffondersi del morbo; altre distruzioni si ebbero nel corso dell’incendio del 1730.
(segue la seconda parte)