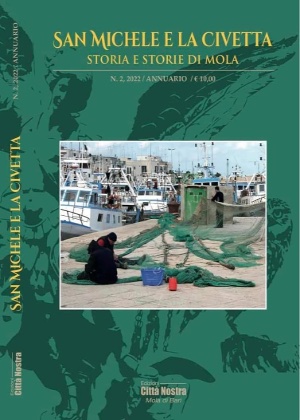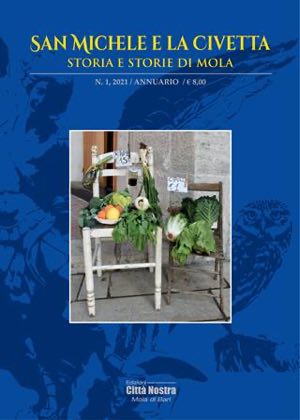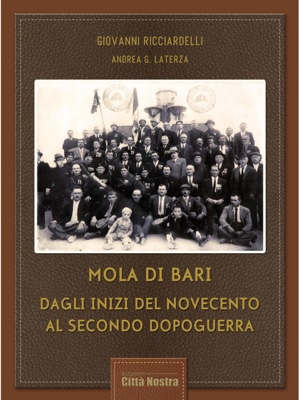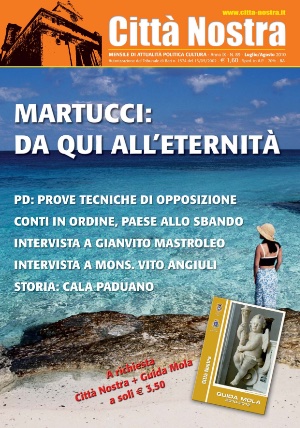di Giovanni Miccolis
II parte
Dopo la peste del 1690-1692 i lasciti, i legati, le donazioni e le disposizioni testamentarie dei fedeli molesi determinarono l’aumento progressivo del patrimonio del Capitolo e degli Ordini Religiosi presenti sul territorio. Alla metà del 1700: il Capitolo Collegiale possedeva 843 opere di terreni, così come indicato nella “Platea dei Beni Capitolari”; i Domenicani possedevano 862 opere; le monache di Santa Chiara avevano 137 opere; i francescani erano, per così dire, i più poveri, tanto che si occupavano di commercio che fu ritenuto attività di contrabbando.
Nel 1659, ai tempi dell’arciprete Angelo Antonio Zuccarino (1627-1680), la Collegiata aveva un arciprete, due primiceri, 23 canonici, 74 sacerdoti.
Fecero seguito gli arcipreti: Giuseppe Zuccarino (1680-1725), Valeriano Fanizza (1725), Antonio Cerulli (1726-1727), Valeriano Fanizza (1727-1728), Michele L. Bardi (1728-1739), Valeriano Fanizza (1739).
 Nel 1753, ai tempi dell’arciprete don Sante Noya (1739-1758), il capitolo molese si componeva di un Arciprete, due Primiceri, 24 canonici ed un numero illimitato di preti extranumero. E’ facile immaginare quanti problemi dovettero esservi tra i membri del clero, interessati a conquistare prerogative e diritti nella gestione dell’immenso patrimonio della “Platea dei Beni Capitolari” di ben 851 opere e 22 ordini nel 1787. Da Michele Garruba (Serie critica de’ sacri pastori baresi…, 1844) si rileva che nella Collegiata di Mola: “si assegnino ducati 200 all’Arciprete parroco per la sua congrua; si stabiliscano 24 porzioni maggiori per ducati 65 l’una, da servire per i 24 canonici quoad honores; sei porzioni minori in ducati 50 l’una e che il residuo in grani 81 s’impieghi secondo la regola generale di dividersi tra’ partecipanti alla fine dell’anno…”.
Nel 1753, ai tempi dell’arciprete don Sante Noya (1739-1758), il capitolo molese si componeva di un Arciprete, due Primiceri, 24 canonici ed un numero illimitato di preti extranumero. E’ facile immaginare quanti problemi dovettero esservi tra i membri del clero, interessati a conquistare prerogative e diritti nella gestione dell’immenso patrimonio della “Platea dei Beni Capitolari” di ben 851 opere e 22 ordini nel 1787. Da Michele Garruba (Serie critica de’ sacri pastori baresi…, 1844) si rileva che nella Collegiata di Mola: “si assegnino ducati 200 all’Arciprete parroco per la sua congrua; si stabiliscano 24 porzioni maggiori per ducati 65 l’una, da servire per i 24 canonici quoad honores; sei porzioni minori in ducati 50 l’una e che il residuo in grani 81 s’impieghi secondo la regola generale di dividersi tra’ partecipanti alla fine dell’anno…”.
Con tali disposizioni l’arciprete, i canonici e sei preti potevano vivere in concreto di rendita. Ed erano proprio gli stessi che beneficiavano anche degli introiti per le “intenzioni” dei fedeli più agiati. Nelle chiese erano celebrate anche venti messe giornaliere, quasi tutte per onorare le pie intenzioni delle varie famiglie, spesso facoltose. Gli altri preti dovevano svolgere, oltre al ministero sacerdotale, anche altra attività, spesso per la coltivazione dei terreni.
A Sante Noya fecero seguito: Francesco Lauro (1758), Ambrogio Petrella (1758-1759), Emilio De Marinis (1759), Ambrogio Petrella (1759), Nicola Vitulli (1759-1775), Giacomo De Marinis (1775-1779), Giovanni Martinelli (1779-1813).
Nel 1788 era in viaggio Pietro Paolo Remon, castellano di Gallipoli, che era stato nominato Preside della Provincia di Catanzaro e che stava raggiungendo la sua nuova sede col segretario Bartolomeo Ravenna. Il segretario scrisse un “Diario” nel quale annotò le sue impressioni sui luoghi visitati.
 Il sei gennaio giunsero a Mola ed alloggiarono nell’albergo cittadino. Subito li raggiunse don Ermenegildo Pepe, il quale si rammaricò per la sistemazione poco consona agli illustri visitatori e fece le sue lagnanze al preside Remon per non essersi recato nel suo palazzo unitamente al segretario. Bartolomeo Ravenna scrisse nel suo Diario che Mola era una città “piccolissima, per cui non potendo abitare nel recinto delle sue mura, la sua numerosa popolazione composta di circa ottomila persone, si è costruito al di fuori un gran borgo, il quale si è talmente ampliato che quasi tutta la popolazione, e la più culta, abita in questo borgo, restando ora di dentro poca gente e della più popolare”.
Il sei gennaio giunsero a Mola ed alloggiarono nell’albergo cittadino. Subito li raggiunse don Ermenegildo Pepe, il quale si rammaricò per la sistemazione poco consona agli illustri visitatori e fece le sue lagnanze al preside Remon per non essersi recato nel suo palazzo unitamente al segretario. Bartolomeo Ravenna scrisse nel suo Diario che Mola era una città “piccolissima, per cui non potendo abitare nel recinto delle sue mura, la sua numerosa popolazione composta di circa ottomila persone, si è costruito al di fuori un gran borgo, il quale si è talmente ampliato che quasi tutta la popolazione, e la più culta, abita in questo borgo, restando ora di dentro poca gente e della più popolare”.
Il clero di Mola non fece una buona impressione ai viaggiatori, anzi suscitò molta ilarità il loro comportamento. Pungente fu un’osservazione del Ravenna, il quale obiettò che i canonici non erano nominati per merito “ma per anzianità, motivo per cui, essendo tutti decrepiti poco pensavano alla pulizia”. Il segretario fu ancora più offensivo nei confronti del clero dopo aver incontrato un corteo funebre; con irriverente sarcasmo definì alcuni ecclesiastici “veramente da teatro”.
Erano tanti gli appartenenti al clero e non tutti brillavano per fervore religioso, per idoneità, per correttezza nei costumi. Tuttavia, se l’aspetto e l’atteggiamento dei prelati molesi lasciavano a desiderare, ad essi doveva comunque riconoscersi il bagaglio culturale acquisito con il tirocinio presso le sedi vescovili e con gli studi nella capitale, Napoli. Erano gli insegnanti, educatori e precettori dei figli delle famiglie agiate, prima della istituzione di scuole regolari.
Scuole pubbliche con insegnanti laici furono istituite verso la fine del 700. Il testamento di Luigi Tanzi, con il quale si fondava in Mola una scuola secondaria da amministrarsi da una Commissione eletta dal Municipio, risale al 4 luglio 1799.
Gli arcipreti dell’800 furono: Ermenegildo Pepe (1813-1817), Giovanni Berardi (1817-1818), Vito L. Intini (1818-1848), Giuseppe Affaitati (1848-1868), Antonio M. Capozzi (1869-1874), Vincenzo Susca (1874-1902).
Alcuni preti parteciparono con fervore alle attività rivoluzionarie dei Carbonari in un mondo che cambiava e che chiedeva maggiori diritti e libertà dalla tirannia dei sovrani.
Nel “Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli” di Lorenzo Giustiniani (Napoli, 1816) Mola era così descritta e conosciuta: «Mola di Bari città regia della provincia, che porta il nome appunto di Bari, e per distinguerla dall’altra appellata di Gaeta, va così nominata nella carte. Dista miglia 12 da Bari e si vuole antica, ma non sappiamo assegnare alcun’epoca di sua fondazione. Nel 1117, quando governava Costanza la città di Bari in nome di Boemondo suo figlio, era un luogo di non molta considerazione. In oggi è grande per ragione dei suoi borghi. Nella medesima vi si vedono delle buone fabbriche di chiese e di edificj. Vi sono tre Monti di Pietà una Regia dogana ed il fondaco di sale. La tassa de fuochi del 1532 fu di 464, nel 1545 di 745, nel 1561 di 770, del 1595 di 1044, del 1648 anche di 1044, e del 1669 di 1436. Nell’ultima del 1737 fu di 1043. Nel 1436 da Alfonso I fu venduta a Landolfo Maramaldo per ducati 6.300. Per la sua ribellione nell’anno 1446 da Ferdinando fu venduta a Niccolò Toraldo, nella cui discendenza si conservò fino al 1551, quando ad istanza de creditori fu venduta insieme colla terra di Polignano a Giovanni Francesco Carafa per ducati 35.000. Nel 1583 fu poi venduta a Vincenzo della Tolfa per ducati 50.000. L’università cercò il Regio demanio, ed avendolo ottenuto, vendè tutti i corpi feudali al Conte di Conversano per ducati 53.500».
Il 29 aprile 1813 fu nominato arciprete don Ermenegildo Pepe. La sua fu una gestione travagliata, non per i tumulti e le sommosse popolari che erano ormai un ricordo, ma per le continue pretese dei canonici della Collegiata in una città che prosperava con i suoi commerci ed aveva superato i 9 mila abitanti. Con la ricchezza di tante famiglie molesi aumentarono, allo stesso tempo, l’autorità del Clero ed il potere dei canonici. Questi, durante le funzioni religiose, avevano il diritto di occupare gli stalli superiori del coro e di indossare l’almuzia (piccolo mantello di pelliccia che completava la cappa corale). Il 16 settembre 1815 l’arciprete concesse, con parere favorevole dell’arcivescovo Baldassarre Mormile, la cappa magna (ampio mantello con strascico). Occorrevano molta diplomazia e notevole pazienza per amministrare i numerosi religiosi e queste doti non mancavano al buon Ermenegildo, molto apprezzato dalla Nunziatura di Napoli.
 L’ottocento fu un periodo molto tormentato anche per il clero molese, poiché le leggi dei Borbone, sulla scia di quelle francesi, portarono sostanzialmente alla diminuzione del potere temporale della Chiesa. La popolazione aumentava e diminuivano il numero dei preti e la platea dei loro beni.
L’ottocento fu un periodo molto tormentato anche per il clero molese, poiché le leggi dei Borbone, sulla scia di quelle francesi, portarono sostanzialmente alla diminuzione del potere temporale della Chiesa. La popolazione aumentava e diminuivano il numero dei preti e la platea dei loro beni.
Nel 1848, in ogni modo, la Chiesa di Mola era ancora riconosciuta come “ricettizia numerata” con un arciprete, 24 canonici e sei partecipazioni della ricettizia numerata.
Nel 1855 fu richiesta dall’arcivescovo di Bari, mons. Michele Basilio Clary, l’elevazione del Capitolo di Mola a Collegiata Insigne di “vera natura” e non soltanto di puro titolo. La richiesta fu accolta con bolla del papa Pio IX, munita di regio exequatur del 24 ottobre 1857, e resa esecutiva il 28 novembre 1857.
Non ebbe esito positivo invece l’istanza per attribuire le insegne minori corali al ceto inferiore dei Mansionari, rivolta a Ferdinando II nel gennaio 1859 mentre transitava febbricitante da Mola e diretto a Bari per incontrare Maria Sofia di Baviera, promessa sposa del figlio Francesco II.
Con le leggi del decennio francese sull’eversione della feudalità, con l’assoggettamento dei vescovi al sovrano borbonico al quale dovevano giurare fedeltà, con le successive leggi eversive dello Stato Italiano del 1866 e del 1867, con la vendita o la confisca dei beni ecclesiastici, si verificò la disgregazione della comunità soprattutto parrocchiale. I sovrani borbonici utilizzarono il clero per controllare il consenso delle masse sulle attività di ordine pubblico e sanitario (con decreti e dispacci i parroci erano chiamati ad intervenire anche per sollecitare la popolazione a vaccinarsi).
Dopo l’Unità d’Italia, con petizione n. 10.863, Bellantuono Francesco e altri sei sacerdoti addetti al servizio della chiesa cattedrale di Mola di Bari si rivolsero alla Camera, perchè fossero rispettati i loro diritti nella conversione dell’asse ecclesiastico.
Nella seduta del 24 gennaio 1866 il deputato Lazzaro disse: “Chiedo alla Camera che si compiaccia di dichiarare di urgenza la petizione 10,863, mediante la quale alcuni appartenenti al clero così detto fuori numero, cioè non beneficiato, della città di Mola di Bari, domandano che la loro petizione sia presa in considerazione allora quando la Camera delibererà sulla legge dell’asse ecclesiastico”.
Poco dopo, con legge per la liquidazione dell’asse ecclesiastico del 15 agosto 1867, il Capitolo fu soppresso.
La popolazione molese era nel 1815 di 8.388 abitanti, passando a 12.574 nel 1861 (Unità d’Italia) ed a 13.962 nel 1901; nello stesso tempo la popolazione dell’intera provincia era di 339.309 abitanti nel 1815, 554.042 nel 1861 e 827.698 nel 1901.
All’inizio del 1900 era aumentata notevolmente la popolazione ed era diminuito il numero dei sacerdoti. Tre erano le “associazioni partitiche”: Repubblicano, Monarchico, Clericale. La fine del secolo diciannovesimo era stata caratterizzata da scioperi e rivolte nelle campagne, dall’insofferenza dell’ingerenza della Chiesa nella gestione pubblica, dalla nascita del pensiero socialista. Saverio La Sorsa ritenne così la situazione politica barese: «…sezione socialista che ha pochi iscritti…i repubblicani si contano sulle dita…la sezione radicale è ancora nascente…il partito clericale si mostra meglio disciplinato» (La vita di Bari durante il secolo XIX, Bari 1915).
Era diminuito il numero delle messe celebrate nelle chiese e vi era una “incredulità dilagante” come nel resto della provincia.
L’ingaggio dei salariati agricoli avveniva nei pressi della Chiesa di San Domenico con una paga “al ribasso”: scarsa era l’offerta di lavoro e c’era sempre qualcuno che si offriva ad un prezzo inferiore a quello precedentemente pattuito.
Gli arcipreti dell’inizio del secolo ventesimo furono: Angelo Roberti (1902-1903), Gennaro Mansione (1903-1919), Giuseppe Palumbo (1919-1920), Pietro Novelli (1920-1927).
Una visita “ad limina” (alle soglie del secolo) era stata compiuta dall’arcivescovo Giulio Vaccaro (1851-1924) in tutta la diocesi di Bari. Una nuova e più accurata visita fu affidata nel maggio 1907 al redentorista Ernesto Bresciani (1838- 1919), dal cardinale Gaetano De Lai. In Puglia il Bresciani visitò le diocesi di Bari, Conversano, Monopoli, nonché le chiese palatine di Altamura, Acquaviva, San Nicola di Bari e Monte Sant’Angelo.
Dalla relazione del visitatore si desumono i seguenti sintetici elementi relativi alla nostra città.
La Collegiata di Mola era retta dall’arciprete, anche con la funzione di parroco (non esistevano altre parrocchie), e da sette viceparroci.
Il parroco aveva il compito dell’insegnamento del Vangelo e del Catechismo agli adulti ed ai bambini; erano a suo carico anche le predicazioni nelle diverse occasioni dell’anno liturgico.
I viceparroci si alternavano, due per volta, in turni settimanali per la cura dell’amministrazione dei sacramenti e per l’assistenza degli ammalati. Non potevano essi confessare le donne.
Nelle messe domenicali era obbligatoria l’omelia (il sermone).
Il catechismo dei fanciulli era spesso trascurato e limitato in alcuni periodi dell’anno, perchè i ragazzi delle famiglie non facoltose erano impiegati spesso nei campi e nelle attività artigianali. Se deficitario era il catechismo dei fanciulli, quello degli adulti era pressoché sconosciuto.
Le predicazioni erano invece svolte con regolarità.
Il clero non ricevette un giudizio lusinghiero: «I vecchi, ignoranti ed avvezzi a far nulla, in passato hanno piuttosto scandalizzato il popolo e non hanno idea della vita e del ministero sacerdotale». Alcuni preti avevano prole e non provavano alcuna vergogna. Diversi giovani preti non avevano sufficiente vocazione e cultura teologica: «Uno si è fatto prete per godere 12.000 lire lasciate dal nonno, un secondo era fornaio, un terzo falegname, un quarto calzolaio, e tutti incominciano tardi gli studii, e li compirono alla meglio. Dal vedere poi come si combattono per guadagnare pochi soldi, e come assistevano alle funzioni fino all’anno scorso, e facciano i Preti per mestiere».
L’arciprete don Gennaro Mansione, comunque, fu giudicato buono, rispettato e zelante.
Le scuole comunali femminili erano tenute dalle suore d’Ivrea («Deve ascriversi a speciale misericordia di Dio verso questo paese che da 40 anni tutte le scuole comunali femminili, ora frequentate da 750 bambine divise in 11 classi, sano affidate a dieci buone e brave suore d’Ivrea. Ogni giorno queste insegnano un po’ di dottrina e di storia sacra e approfittano di ogni occasione per istillare sentimenti cristiani…Quest’opera è visibilmente protetta dal Signore, ben veduta da tutte le classi di persone, e perciò tollerate dai massoni. Il Comune con le Suore risparmia L. 2.000 l’anno»).
I Galantuomini furono giudicati «in gran parte atei e frammassoni»; le donne delle classi agiate disertavano volentieri chiesa e sacramenti; nessuno dei Signori «osteggerebbe apertamente la religione se non temesse il popolo».
Il 28 agosto 1927 fu nominato mons. Francesco Bitetto, delegato arcivescovile fino al 1929, e quindi arciprete dal 1929 al 1966. Il 2 aprile 1967 l’arcivescovo Enrico Nicodemo conferì il possesso canonico al nuovo arciprete don Giuseppe Buonsante che fu in carica fino al 1987, anno della sua scomparsa. Per diciassette anni resse la Chiesa Matrice don Fedele Sforza. L’attuale parroco della Matrice è don Mimì Moro.