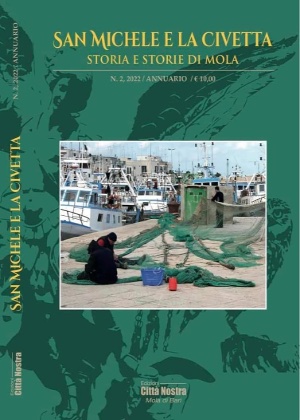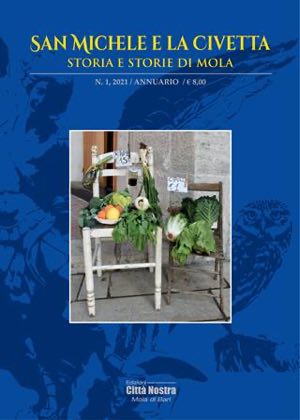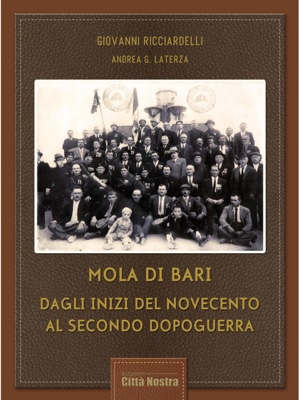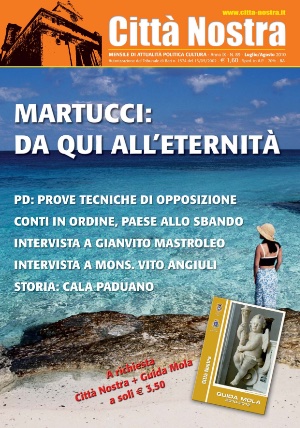di Francesco Mazzotta*
 Una miscellanea di musica klezmer e cliché su nasi lunghi e avidità.
Una miscellanea di musica klezmer e cliché su nasi lunghi e avidità.
È il «Cabaret Yiddish» di Moni Ovadia, l’ebreo errante del palcoscenico atteso con il suo storico spettacolo, venerdi 23 febbraio (ore 21), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per la Stagione 2017-2018 della Compagnia Diaghilev (info e prenotazioni 339.8796764).
Una presenza “naturale”, quella di Ovadia, nella programmazione di Mola, dove sin dal 1995, ai tempi della precedente residenza artistica del Centro Diaghilev, La Casa dei Doganieri, l’artista ha stabilito un rapporto privilegiato.
Adesso un nuovo ritorno con questo vademecum esplorativo delle origini ebraiche nelle terre dell’Europa Centrale, dove affondano le radici culturali di Ovadia, erede della tradizione yiddish – quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno – e unico artista ad aver portato all’attenzione del grande pubblico la cultura ebraica più a est del Vecchio Continente.
Al centro di una scena nuda, riempita solo da quattro musicisti (Maurizio Dehò al violino, Paolo Rocca al clarinetto, Albert Florian Mihai alla fisarmonica e Luca Garlaschelli al contrabbasso), il cantore, senza troppi preamboli, inizia la sua storia con un sorriso, antico ed esperto: il sorriso di chi, fin dall’alba dei tempi, ha dovuto sfruttare l’ironia per far fronte alle proprie disgrazie e ha saputo riciclare aneddoti e storielle per forgiare una sagace oratoria in risposta al razzismo e alle calunnie.
Si potrebbe dire che lo spettacolo abbia la forma classica del cabaret comunemente inteso. Infatti, alterna brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni che la comprovata abilità dell’intrattenitore sa rendere gustosamente vivaci. Ma la curiosità dello spettacolo sta nel fatto di essere interamente dedicato a quella parte di cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica.
 «Ho scelto di dimenticare la “filologia” – spiega Ovadia – per percorrere un’altra possibilità, proclamando che questa musica trascende le sue coordinate spazio-temporali “scientificamente determinate” per parlarci delle lontananze dell’uomo, della sua anima ferita, dei suoi sentimenti assoluti, dei suoi rapporti con il mondo naturale e sociale, del suo essere “santo”, della sua possibilità di ergersi di fronte all’universo, debole ma sublime». È la «musica della dispersione, il suono dell’esilio», come la chiama Moni Ovadia»: in un altre parole, «la musica della diaspora», che Ovadia porta in scena in uno spettacolo che «sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe».
«Ho scelto di dimenticare la “filologia” – spiega Ovadia – per percorrere un’altra possibilità, proclamando che questa musica trascende le sue coordinate spazio-temporali “scientificamente determinate” per parlarci delle lontananze dell’uomo, della sua anima ferita, dei suoi sentimenti assoluti, dei suoi rapporti con il mondo naturale e sociale, del suo essere “santo”, della sua possibilità di ergersi di fronte all’universo, debole ma sublime». È la «musica della dispersione, il suono dell’esilio», come la chiama Moni Ovadia»: in un altre parole, «la musica della diaspora», che Ovadia porta in scena in uno spettacolo che «sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe».
Attraverso singole «storielle», l’artista si propone di far ridere e al contempo di far emergere quel fondo di verità tipicamente popolare per spiegare i cardini della cultura sionista, dal dialogo con il divino a quello con la famiglia matriarcale, passando per il rapporto con il denaro, i caratteri somatici, il razzismo e il confronto con le altre religioni. E con una cifra stilistica inconfondibile, sceglie la leggerezza lasciando grande spazio alla musica, con la quale persino il testo diventa pura sonorità. «Gli umili che hanno creato tutto ciò prima di poter diventare uomini liberi – conclude Ovadia – sono stati depredati della loro cultura e trasformati in consumatori inebetiti, ma sono comunque riusciti a lasciarci una chance postuma, una musica che si genera laddove la distanza fra cielo e terra ha la consistenza di una sottile membrana imenea che, vibrando, magari solo per il tempo di una canzonetta, suggerisce, anche se è andata male, che forse siamo stati messi qui per qualcos’altro».
*Addetto stampa