Di Vito Luigi Campanile
Vito Luigi Campanile, studente universitario di ventisei anni, attualmente oltre a studiare alla magistrale di Bergamo Culture Moderne Comparate (è la magistrale di Lettere), fa l’educatore in un Centro Diurno per minori come volontario del Servizio Civile. Nato a Mola, ha sempre vissuto a Bergamo e ci racconta la sua esperienza a Bergamo in questi giorni terribili. Quella che segue è la prima di cinque puntate della sua testimonianza rilasciata a “Città Nostra”, nella quale descrive il dramma vissuto in una città stretta tragicamente dall’emergenza coronavirus. Ne pubblicheremo una al giorno.
Che nella mia città – Bergamo – la situazione non sia normale, lo capisco dalla presenza sotto casa di un auto della polizia che alle tre di notte procede a passo lentissimo con un faro bianco sul tettuccio come se stesse cercando qualcosa.
Se fossimo nella normalità, nel ravvisare la presenza della polizia di Stato sotto casa sobbalzerei stupito.
Chi ha ammazzato chi? Qualcuno smercia sostanze stupefacenti nel condominio e non me ne sono accorto? Qualche furto?
Queste sono le domande che mi porrei. E invece nessuna sorpresa in me; appena il mio occhio intravede da lontano l’auto della polizia, l’associazione mentale è istantanea: si stanno assicurando che nessuno bazzichi in giro per evitare il contagio del Covid 19. La calma con cui reagisco alla presenza della la polizia sotto casa è la prova evidente che non è una situazione ordinaria; il fatto che sia normale vederla qui mostra che non stiamo vivendo normalmente.
È buio nel mio soggiorno, e io continuo a passeggiare pensando a quei due di là, che dormono – sembra – serenamente.
Papà e mamma sono entrambi molesi, si sono conosciuti a Mola e si sono sposati a Mola; sono ventinove anni che vivono a Bergamo, trasferiti qui per il solito leitmotiv “Non c’è lavoro” (nonostante qualche tentativo sibillino di nonno rivolto a mia madre “Non puoi farlo a Rutigliano il concorso?”); io sono nato a Mola per caso, perché d’estate mia madre si trovava in Puglia, e alla reiterata domanda “Preferisci vivere a Bergamo o a Mola?” ho sempre dato risposte vaghe, preferendo rifugiarmi in una replica evasiva: “Se ci fosse una nazionale del Sud e una del Nord, io risponderei solo alla chiamata della prima”.
Siccome nella vita non faccio solo il figlio di molesi emigrati, ma anche lo studente universitario, e temporaneamente – offrendo aiuto come volontario del Servizio Civile – l’educatore in un Centro Diurno per minori provenienti da situazioni familiari difficili e a rischio emarginazione, penso anche ai miei ragazzi.
Ce n’è uno che è un ragazzo difficile: ebbene, in questi giorni di reclusione a casa studia silenziosamente e suona il violino.
C’è n’è un altro che dice qualsivoglia menzogna pur di fare i suoi interessi: in queste giornate ho deciso di sottoporlo ad un’intervista esistenziale, nella quale alla domanda “Quando non ti sei piaciuto?” lui ha risposto “Quando faccio qualcosa io e viene accusato qualcun altro”.
I miei ragazzi, continuamente irrequieti e maldisposti verso gli altri, che vanno dai tredici ai sedici anni, hanno capito, hanno compreso.
Tutte le energie e le ore spese per spiegar loro il concetto di bene comune, di responsabilità collettiva, del nulla che rimane dopo la violenza, sono state canalizzate nello sguardo alla finestra della casa di ognuno di loro.
Le strade più trafficate sono deserte, tanto da poterci camminare senza adoperare il marciapiede; gli uccellini sono gli unici che hanno il diritto di cantare, perché ogni nota realizzata con voce umana risulterebbe stonata; le ambulanze sono più frequenti di quel famoso intercalare bergamasco “Pota!”; di notte c’è una differenza fondamentale tra il silenzio di prima e quello di ora: non c’è anima viva in giro non semplicemente perché sia notte e si deve dormire, bensì perché ti sentiresti in difetto rispetto a chi sta male; ti sentiresti come se ti fossi messo a ridere fragorosamente, tirando ogni tanto un morso ad un panzerotto tenendo nell’altra mano una peroni, nel momento in cui si sta chiudendo definitivamente la bara durante un funerale.
E di giorno invece? Che succede?
Qualche giorno fa Stefano mi ha telefonato mentre ero seduto sul water – e non c’era traccia di comicità nella situazione, non poteva esserci.
“Vito…”
Il modo con cui ha pronunciato il mio nome, così diverso da tutte le altre volte.
“Si tratta di nonna, vero?”
“Vito, è finita”.
E poi incominciava a farfugliare qualcosa, completamente disorientato. Non aveva il coraggio di chiamare il suo datore di lavoro, proprietario di una pizzeria d’asporto, per dirgli che probabilmente la nonna è morta di Coronavirus (il tampone confermerà poi due giorni dopo che è deceduta per il Covid 19).
La signora era un anno che non usciva di casa, per l’età molto avanzata, ma qualcuno dei familiari, da fuori, ha portato il virus all’interno dell’abitazione.
Questo amico mio è molto arrabbiato con il capo, e lo invito subito a comunicare la notizia ai colleghi e al datore di lavoro.
“Proprio tu che sei indignato verso di lui, perché continua a tenere aperta l’attività nonostante stia bene economicamente solo per approfittare della mancata concorrenza, proprio tu che ti sei accorto subito del pericolo di lavorare in una cucina piccola e stretta, adesso hai il dovere di comunicare a tutti quanti cosa è successo, sapendo che potresti essere infettato anche tu”.
Sussegue poi un domino di emozioni nere nella vita del mio amico, che si concluderà con un grosso vuoto: il traguardo è quello.
La madre di Stefano – figlia dell’anziana donna – riceve, nel tragitto per raggiungere casa, dopo che non aveva notizie da ventiquattro ore da parte dell’ospedale, una telefonata.
“Sua madre è deceduta”.
Due giorni prima aveva provato a contattare l’ospedale, e si era sentita dire, in tono brusco e irritato, “Noi diamo notizie solo ai familiari stretti, cosa vuole?”.
Quando poi la mamma di Stefano ha fatto notare che a parlare era figlia della paziente, la segretaria della struttura si ritrova spiazzata; non pensava di avere a che fare con lei, chi risponde alle telefonate ne riceve così tante che non si rende conto del dolore di chi sta parlando, è una sfilza di richieste d’aiuto e vorrebbe anche lei urlare una sorta di “Ma è proprio necessario aggiungere un’altra telefonata?”. Lo è, eccome.
Una mia grandissima amica ha la madre che lavora nella portineria di un ospedale, e ribadisce che “Non ha mai ricevuto così tante telefonate dall’obitorio”. La mascherina della madre è costantemente sul volto, e il timore di non poterla più togliere di dosso e che sia obbligata a tenerla sempre, è molto forte in lei: vorrebbe, una volta a casa, sempre gettare via, quella mascherina, come a incarnare l’allontanamento e il disprezzo verso il virus. La mia amica dice che sente un’enorme masso dentro di sé ogni volta che vede uomini seminudi in terapia intensiva. Nel sentirmi dire ciò, penso a questa forte ambivalenza: la speranza di vedere sempre gettata via la mascherina, associato al terrore nel vedere in tv uomini sprovvisti di vestiti all’ospedale; il desiderio di vedere un volto scoperto causato dall’angoscia di vedere qualcuno nudo; quindi chiedo, solo nella mia mente e non direttamente a lei, “Francesca mia, ti fa paura il coperto o lo scoperto?”; lo sento però che nei suoi messaggi frenetici mi sta dicendo “Coperto e scoperto, dolce e salato, sole e pioggia, bianco e nero, tutto mi fa paura Vito”.
E torniamo al domino di emozioni nere di Stefano. Delega ad un amico la comunicazione della notizia da dare al datore di lavoro, perché dopo la morte della nonna non ci sta capendo più nulla. Vede la madre piangere, e si arrabbia terribilmente verso il padre perché pensa solo a salvare i soldi in banca, in vista secondo lui di una possibile crisi finanziaria.
“Vergognati, sei una merda. Vergognati”.
Questo caro amico mi ha sempre detto che le confidenze alle persone non le vuole dare, che difficilmente si apre agli altri, che si tiene veramente – di numero – due amici stretti e agli altri non dice mai nulla, soprattutto ai suoi genitori, perché non si è mai sentito capito. E questa situazione l’ha trasformato, perché finalmente ciò che racconta intimamente a me, lo grida in faccia al padre. Tutto è cambiato.
La sorella di Stefano, molto legata alla nonna, è tremendamente sofferente.
“Vito, adesso mia sorella soffrirà parecchio. Non ce la faranno nemmeno vedere, chissà come la saluteremo. Non adesso, non doveva morire adesso”.
Niente camera ardente, in pochi sanno della scomparsa di questa signora, nel paese nella bergamasca che conta cinquemila anime. Anche i manifesti non verranno visti (Stefano ne vedrà uno soltanto una settimana dopo, con una fotografia via Whatsapp). Tutti sono impegnati a salvarsi. Nelle animate discussioni a proposito dei social, se l’uso sia sano o meno, finalmente la luce. Ecco a cosa servono! A comunicare che una donna è morta nei periodi di pandemia, altrimenti nessuno lo sa! Il mio amico scrive un post su Facebook, e tantissimi solo in quel modo apprendono la notizia. Ma non c’è tempo per vivere il dolore, si deve svolgere il funerale. Altra contraddizione di questi tempi in cui l’anormale diventa normale, in cui le regole del gioco sono cambiate: i funerali non servono proprio a vivere il dolore? No, con il Covid 19 che infesta non è più così. Il rito funebre si svolgerà in quattro persone – figlia, due nipoti, il genero – e senza possibilità di abbracciarsi.
La madre di Stefano piange a dirotto, quando inseriscono la bara nel loculo. Ma lui non può fare nulla, non può intervenire per placare il suo dolore, nessun bacio o abbraccio. Di conseguenza, aumenta anche il suo. È come ricevere una martellata al dito e vederti tappata violentemente la bocca. Ecco il vuoto. Non quello fisico, tra un loculo e l’altro, che viene riempito dalla bara, ma quello – sacrosanto! – del nulla che si vorrebbe riempire con la nostra sofferenza. E invece non è permesso. Non ci si può abbracciare, il vuoto rimane vuoto, e il dolore continua a scorrere nelle vene, imprigionato in Stefano.
(continua)





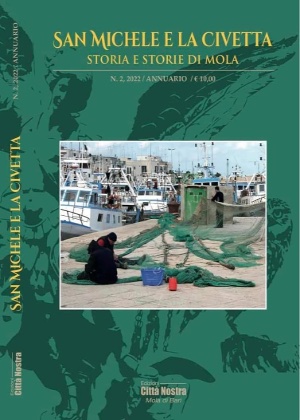
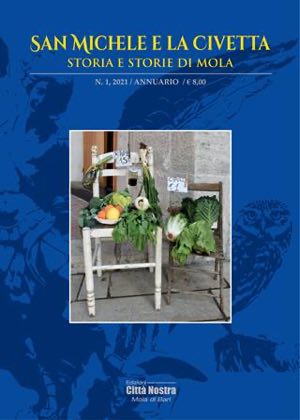






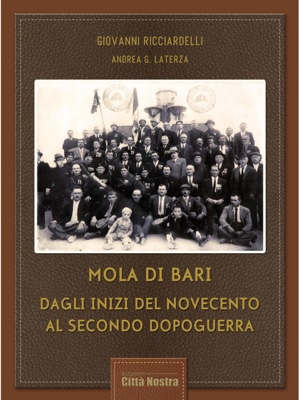

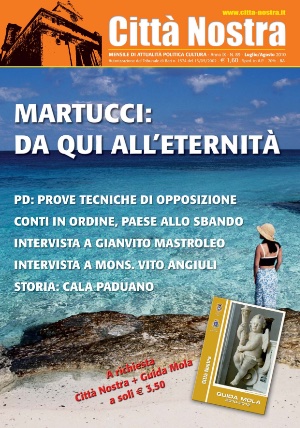


Salve, sono l’autore dell’articolo. Mi permetto di dirle che ha centrato, senza volerlo, appieno il senso del mio testo.
Lei avrebbe tutte le ragioni del mondo se le persone si fossero fermamente adeguate alle disposizioni del Governo. Siccome così non è, ho volutamente raccontare il male che stiamo vivendo per evitare che si propaghi nella nostra amata terra. L’intento è proprio quello di sensibilizzare tutti al problema, perché a me hanno riportato – su richiesta anche di uno dei redattori – che tanti non hanno (avevano) capito con che male si ha a che fare. E quando non si comprende il male, non è mai perché la gente è stupida o menefreghista, ma perché semplicemente il male non lo ha visto (quando dico ‘male’ mi riferisco al male di questa situazione), o se l’ha visto, non è stato ancora sufficiente.
Una volta capito con che si ha a che fare, allora si potrà essere ancora più determinati e coraggiosi.
Se leggerà il proseguo del racconto, vedrà che il problema di Bergamo e di tutto il Nord è stato di non aver capito bene con che guaio si aveva a che fare. Mola e tutto il Sud ha il grande vantaggio di vedere cosa è successo a Bergamo e agire di conseguenza.
Altrimenti, secondo me è come diceva un grande uomo del 1800.
“Il genere umano non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina”.
Cari saluti,
un dolce abbraccio e forza Mola.