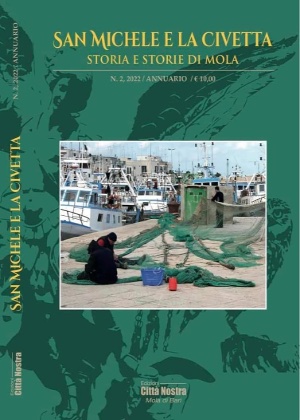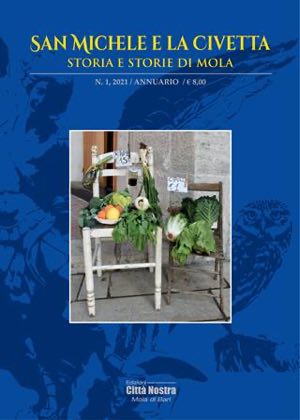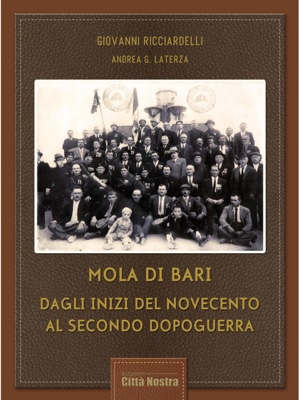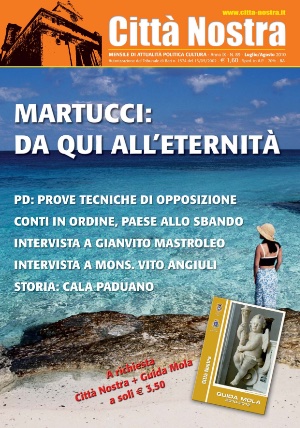di Vito Luigi Campanile
[…] Nel giorno seguente al funerale, la mamma di Stefano telefona all’ospedale per sapere l’esito del tampone a cui l’anziana donna si è sottoposta prima di morire.
All’ospedale si erano dimenticati di far sapere com’è andato il test; se lo non avesse domandato la famiglia della deceduta, l’esito forse sarebbero andati perduto. Positiva al virus. Oltre al dolore, scorre ed è presente nel corpo di Stefano anche un’altra cosa. Forse il Covid 19, forse no, ma sicuramente è presente il sospetto che sia stato lui – Stefano, suo nipote – ad infettare nonna.
O forse la sorella? O forse la madre? O la badante? Questi i quesiti che affollano nella mente del mio amico. Le persone che l’hanno vista sono sette e otto, e il fatto che lei, soltanto lei, non uscisse di casa, non è bastato ad evitare il fattaccio.
Troppe sette o otto persone che uscivano dalla propria casa per entrare nella sua. Il mio amico ci sa fare con i numeri, e prova allora a capire in quali giorni la nonna potrebbe aver contratto il virus. “Ma a che serve?”, mi domando io tra me e me. Poi si passa dai numeri alle identità: inizia la ricerca silenziosa di chi potrebbe aver trasmesso il virus.
La sorella, ormai quasi un mese fa, è andata a contatto con il dottore del paese, stringendogli la mano, il quale in seguito si è rivelato essere positivo anche egli al virus. Viene pubblicata la notizia da parte del Corriere della Sera – quotidiano ritenuto autorevole e attendibile – che alcuni sintomi del Covid 19 consisterebbero nella perdita dell’olfatto e del gusto, specie a quanto pare nel periodo finale dell’infezione, ovvero quando il paziente è sulla via della guarigione (è una notizia questa rinvenibile sul web da chiunque).
Potrebbe essere così. Stefano mi dice che la sorella, e diverse persone nella provincia bergamasca, stanno accusando questa mancanza di sapori e di odori. Sostiene che quindi sia probabile che la sorella abbia contratto il virus. Ha paura di comunicarglielo, perché non solo metterebbe in agitazione lei, suo marito e i suoi due figli, ma sa che scatterebbe in lei il senso di colpa perché potrebbe essere l’indiziata numero uno ad aver trasmesso il virus alla cara nonna.
Il Covid 19 ha invaso ogni stadio temporale: il passato il presente e il futuro. È sia retroattivo che prospettico.
E non solo, tocca le varie sfumature dell’animo umano. Non si limita al dramma. Da quando Stefano mi dà la notizia, mi preoccupo un po’ anche io. Faccio qualche domanda a me stesso, e poi un’indagine segreta ad altri componenti della famiglia.
“Mammà, come sono i finocchi lessi?”
“Buoni”
“No, intendo a livello qualitativo. Salati, dolci?”
“Sento il sapore delicato”.
Allora poi aggiungo, trionfante per la buona notizia, “Mmm buoni! Come si sentono!”. Mi sembra di essere Fantozzi quando è costretto a manifestare l’apprezzamento per il cibo mentre mangia in un ristorante giapponese, per dissuadere il samurai alla sua destra dal proposito di tagliargli la mano, come ha appena fatto ad un altro cliente che non ha approvato la pietanza. Anche la comicità viene contemplata ai giorni d’oggi, ma solo a piccoli tocchi. Poi si ritorna alla desolazione, non per forza legata alla morte di qualcuno.
Stefano riceve messaggi inquietanti da parte del capo. Non sta male, è in salute. Tuttavia comunica a tutti i dipendenti che farà pagare loro a caro prezzo la richiesta – accolta – di chiudere l’attività. Dice che non concederà nessuna ferie, che anche ai supermercati si rischia di contrarre il virus, che loro avevano la possibilità di farcela e dovevano lavorare per chi non può farlo (e Stefano mi ha detto “La possibilità di farcela e di non farcela è quella che riguarda la vita, non il lavoro; altro che portare le pizze”), e che – udite udite – in realtà non voleva sbandierarlo, ma lui voleva lavorare per donare dei soldi all’ospedale di Bergamo, dimenticando però che il giorno prima, quando ancora si doveva decidere se chiudere o meno la pizzeria, optava per mantenerla aperta perché altrimenti, così diceva, avrebbe rischiato di chiudere per sempre e di diventare un dipendente anche lui.
Ad aumentare non sono solo i contagiati, ma i sospetti, le accortezze, le attenzioni verso ciò che viene detto e ciò che viene taciuto.
La premura di mamma, verso me e mia sorella, che si è attuata finora, da donna del Sud, attraverso l’acquisto delle nostre pietanze predilette, è neutralizzata dalla consapevolezza che qualche minuto in più per comprare quel dolce o quelle particolari patatine può costare caro. Esce dal supermercato sudando.
Se può risultare anche pratico – e in un certo senso, forse anche romantico – conversare con qualcuno che si trova sotto casa dalla finestra, lanciandogli una mascherina o delle chiavi per aprire l’ufficio di lavoro, lo è meno non dichiarare apertamente le proprio intenzioni.
La domenica, per mio padre, come il vangelo molese predica, è la giornata del ragù. Ciò implica il bisogno di andare a prendere una bottiglia di passata di pomodoro al supermercato l’indomani, e nonostante un perentorio “Tu domani mattina non vai da nessuna parte” da parte di mia sorella, espresso con la stessa solennità di un “In nome di Dio” o “In nome della legge della Repubblica italiana”,
restano i dubbi che papà esca lo stesso a tradimento la mattina presto. D’accordo con mia sorella, mi ritrovo costretto a far sparire tutte le chiavi di casa alle tre di notte, attaccando sulla porta, chiusa a doppia mandata, il post it “Le orecchiette con ragù e virus non le vogliamo”.
Siamo quattro gemelli siamesi in casa: basta che si ammali una persona, per vanificare la quarantena degli altri quattro; la salute di uno è quella dell’altro.
Quando mio padre, approfittandosi di uno squillo al telefono che costringe mia madre ad alzarsi da tavola, mi dice, piano piano e stando attento a non farsi sentire, “Un carabiniere di Bergamo. Quarantasette anni. Un altro morto”, e io me ne sto zitto, perché me lo suggerisce la modalità silenziosa con cui papà mi ha comunicato la notizia, cosa sono? Omertoso o evito di far preoccupare mamma? Cosa è meglio fare?
Basta questo dubbio per capire che non sono sereno, e chissà quanti altri.
Seppur il silenzio è presente nelle strade, è un po’ artefatto. O meglio, è un silenzio obbligato, come quello delle biblioteche, in cui si tace per costrizione, e non perché lo si vuole: nelle menti delle persone è probabile che regni il caos che non ritroviamo più nelle strade.
Forse solo medici e infermieri riescono effettivamente a dichiarare forte e chiaro “Siamo in tremenda difficoltà” oppure “Quando intubiamo un paziente, il paziente guarda me in faccia”. Come a dire: io mi devo sorbire il suo dolore, non Dio, non coloro che bighellonano per le strade. Una mia cara amica infermiera mi dice “Io mai, il giorno in cui mi sono laureata, mi sarei aspettata di vivere una situazione del genere. Mi sento impotente perché le persone stanno male e io non so cosa fare”.
È molto sconfortata e affranta, e il guaio è che lei crede in Dio (è talmente religiosa da applicare fermamente tutti i precetti cristiani, dalla messa domenicale alla castità nonostante il fidanzamento). È più facile per i medici essere dotati di responsabilità morale, perché sono a contatto con il dolore. È più difficile per chi fa il contadino o l’impiegato alle poste o appunto per chi gestisce una pizzeria, ma, ribaltando la faccenda da un altro punto di vista, chi non lavora nell’ospedale ha un’enorme vantaggio: salvare le vite degli altri pur scorgendo il dolore da lontano. Se risulta più difficile perché non vedi il paziente annaspare e chiedere a te disperatamente aiuto, si rivelerà più valoroso se applicato. Se a basket è più difficile fare canestro da lontano, quando si fa centro vale di più. I miei ragazzi del Centro Diurno, così costantemente immersi nella trasgressione e nel piacere che ne deriva, se lascio il cellulare nel soggiorno dell’abitazione alla portata di tutti, se ne disinteressano, se invece lo lascio nell’ufficio di noi educatori chiuso a chiave, me lo prendono e lo fanno sparire.
L’oggetto subisce un’impennata di valore soltanto perché è precluso. Il desiderio di uscire di casa, di vedere il mare, di mangiare un panzerotto o di incontrare la fidanzata, è sacrosanto. Ma se questo oggetto del desiderio – il mare il panzerotto la fidanzata – fosse tutto contenuto in un grande ospedale, e assieme al mare il panzerotto e alla fidanzata, ci fossero i morti, persone intubate, l’ossigeno che rischia di mancare, le grida di amore da parte di chi capisce che sta per andarsene (“Dottore, dica a mia moglie che l’amo”), quell’oggetto del desiderio non conterebbe più nulla. Perché non è proprio possibile dare una pacca sulla spalla in strada a qualsiasi amico se hai accanto a te la sofferenza. Dobbiamo vederla, perché c’è, è presente, anche se non materialmente. Se dovesse comparire materialmente, io temo che Mola non avrebbe neanche il tempo di accorgersene.
Si vince ora, ora che siamo vivi. Prima del dramma che si sta consumando, a Bergamo in tanti – io per primo – hanno sottovalutato quello che sarebbe potuto succedere. Prima che la situazione si aggravasse, un mio amico e una compagna di mia sorella, incontravano clandestinamente i rispettivi partner al supermercato o in qualche via. Anche se la fanciulla piangeva, preoccupata perché si poteva danneggiare in nome dell’amore proprio l’oggetto amato, gli incontri avvenivano lo stesso, forse anche con un pizzico di piacere come quello provato dai ragazzi nel rubare il cellulare nell’ufficio.
E io stupidamente dicevo “Come Romeo e Giulietta!”. Di questi due, vista la situazione, sono rimaste solo le lacrime.
Un altro amico, dopo che gridava al complotto, dopo che riteneva il virus una possibile manovra economica di chissà chi al quale lui non aveva abboccato, dopo che rincuorava un venditore di kebab perché disperato rischiava il fallimento visto che nessuno andava più a mangiare nel suo locale, ora deve rientrare a lavorare in azienda – lui fa il magazziniere – il 30 marzo, salvo nuove direttive del governo.
(continua)