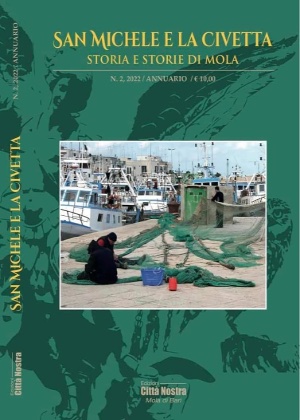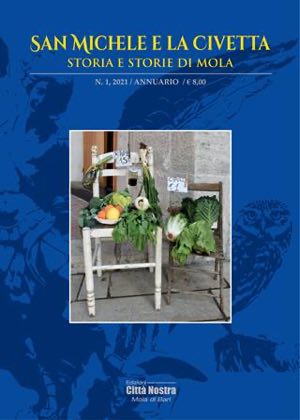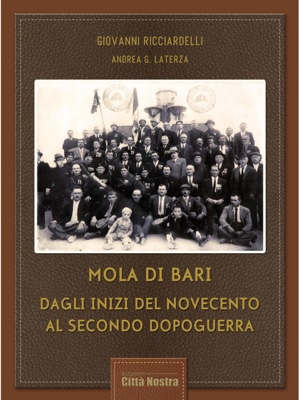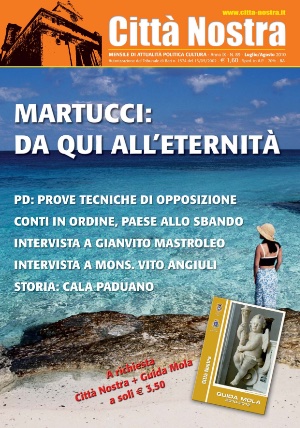di Giacomo Susca*
 Ringrazio il direttore e la redazione di “Città Nostra” e rispondo con piacere all’invito di raccontare la mia esperienza di questi complessi giorni. Lo faccio senza nascondervi un pizzico di emozione: sono trascorsi qualcosa come 25 anni dal mio primo articolo apparso sulle pagine di un periodico molese, era giusto l’aprile del 1995 e si chiamava “La Sveglia”, in una stagione della vita unica e irripetibile di cui conserverò per sempre un dolce ricordo. Oggi, a 39 anni, siedo alla scrivania dell’Ufficio centrale di un quotidiano nazionale, “il Giornale” diretto da Alessandro Sallusti.
Ringrazio il direttore e la redazione di “Città Nostra” e rispondo con piacere all’invito di raccontare la mia esperienza di questi complessi giorni. Lo faccio senza nascondervi un pizzico di emozione: sono trascorsi qualcosa come 25 anni dal mio primo articolo apparso sulle pagine di un periodico molese, era giusto l’aprile del 1995 e si chiamava “La Sveglia”, in una stagione della vita unica e irripetibile di cui conserverò per sempre un dolce ricordo. Oggi, a 39 anni, siedo alla scrivania dell’Ufficio centrale di un quotidiano nazionale, “il Giornale” diretto da Alessandro Sallusti.
Ecco, parafrasando un celebre incipit, vi scrivo da una città che non esisterà più, almeno per come l’abbiamo conosciuta.
Milano città aperta, alle diversità e al cambiamento; Milano che lavora, per etica prima che per profitto; Milano che corre, a volte ti travolge, ma lo fa per raggiungere il futuro prima di tutti. Milano assediata, anzi accerchiata, dal Coronavirus ha dovuto fermarsi. Ha perso una primavera in cui, come sempre, avrebbe mostrato il lato migliore di sé. Ha rinunciato ai suoi eventi internazionali, ha abbassato saracinesche e spento le luci dei grattacieli. Una città in lutto ha pianto i suoi morti e quelli di tutta la Lombardia. Si è genuflessa, ma non si è piegata. Milano resiste nello spazio che intercorre tra dolore e rassegnazione. È andata avanti, oltre gli stradoni deserti e il fischio delle metropolitane nel vuoto, nonostante il mostro la braccasse. I milanesi, al di là di sterili polemiche, hanno risposto con abnegazione e spirito di sacrificio all’appello “restate a casa”. Lo hanno fatto all’inizio con entusiasmo, come quando si affronta una nuova sfida. Smart working, riunioni in videoconferenza, compiti con i bimbi dal divano, pasticci in cucina e canti e applausi dal balcone in onore di medici e infermieri “eroi”. Gesti che nella prima fase dell’emergenza hanno fatto parte di una liturgia quotidiana per scacciare l’angoscia. Poi, con il passare dei giorni in quarantena, è cresciuta l’insofferenza verso l’immobilismo. Milano non può stare ferma a lungo. È fisiologico, non per capriccio o insubordinazione. I milanesi chiedono di ripartire, non appena sarà possibile. Questa gente vuole battere il virus con le armi che ha a disposizione: l’impegno, la fatica e il rispetto delle regole.
Personalmente, ho continuato e sto continuando ad andare ogni giorno in redazione, naturalmente con la massima cautela, munito dei dispostivi di protezione – mascherine e guanti temo ci faranno compagnia ancora per molto tempo, dovunque – e rispettando il distanziamento. L’informazione in una democrazia compiuta rientra tra i beni essenziali e un quotidiano nazionale non può essere ideato e realizzato interamente “da remoto”, perché cerca di descrivere il presente e di interpretare quello che accadrà domani. Il nostro lavoro di giornalisti assomiglia ancora di più a una missione in momenti come quello che stiamo vivendo. Visto da chi vent’anni fa ha fatto quel viaggio verso Nord con molti sogni, desideri e altrettanti sentimenti contrastanti in valigia, devo confessare che assistere alla scena di chi – la notte in cui è stato varato il decreto che ci ha tolto la libertà di movimento – è corso in Stazione Centrale per salire sul primo treno verso il Sud mi ha lasciato sgomento. Mi sono interrogato spesso sulle ragioni profonde di quella fuga. La paura di restare (soli) è un aspetto superficiale della questione. Per qualcuno, il distacco dal paese d’origine non è una scelta ma ancora una ferita da rimarginare. Preferisco però concentrarmi sulla stragrande maggioranza di studenti e lavoratori che sono rimasti a combattere la loro battaglia nell’epicentro del sisma, a i bordi del cratere del vulcano. Senza retorica. A tutti loro, con cui ho avuto modo di confrontarmi, e come a me del resto, se abbiamo avuto la fortuna di conservarci in salute questa sospensione del tempo e dello spazio ha avvicinato ancora di più gli affetti familiari e le amicizie. Abbiamo superato una distanza ben più ampia di quei maledetti 900 chilometri. Una separazione che abbiamo imparato a colmare, almeno in parte, con telefonate, messaggi Whatsapp a tutte le ore del giorno (e della notte), videochiamate e brindisi virtuali. Proprio come è successo in questa ultima, stramba Pasqua di clausura forzata.
Mola è casa. E ci manca, né più né meno di prima. Se oggi a testa alta stringiamo i denti e facciamo ricorso a tutto il nostro senso civico, è per riprenderci presto quello che il mostro vorrebbe toglierci. L’abbraccio della mamma, il sorriso delle nipotine, il rosso dei papaveri nelle lunghe pedalate tra i campi, il sale del vento sulla faccia davanti al mare. Aspettando quella calda sera d’estate, quando il vociare della piazza affollata coprirà finalmente il lamento delle sirene di una notte troppo lunga.
* Giacomo Susca, molese, è giornalista professionista presso Il Giornale, dove dal 2016 è caporedattore centrale