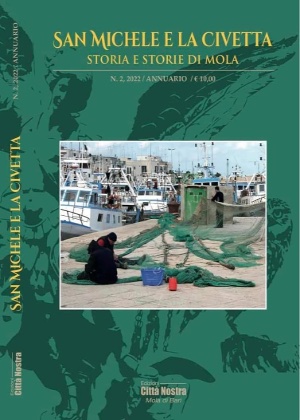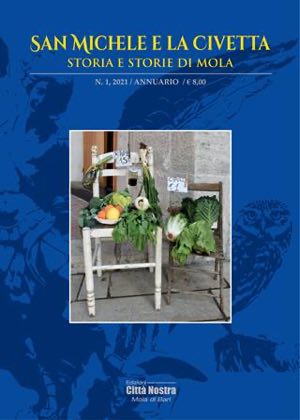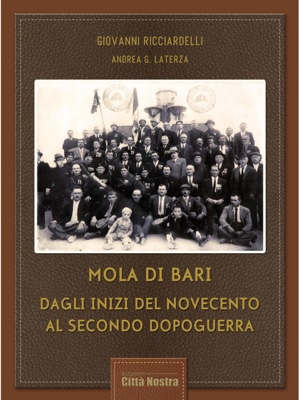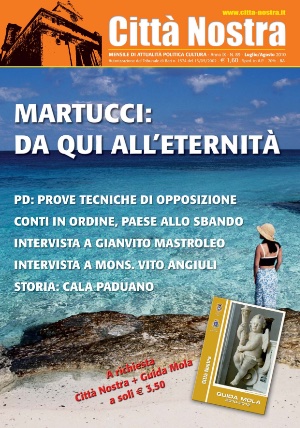di Giovanni Miccolis
Ieri si spenta a Roma Cecilia Mangini, nata a Mola il 31 luglio 1927, la prima documentarista donna in Italia, che seppe dare il ritratto di un’Italia diversa da quella delle narrazioni ufficiali, con coraggio anticonformista. Ripubblichiamo un articolo, a lei dedicato, apparso sul mensile Città Nostra di dicembre 2019.
CECILIA MANGINI
L’infanzia
Cecilia, nata a Mola il 31 luglio 1927, così si raccontò nelle interviste: «Sono nata da papà pugliese e mamma toscana, del Casentino. Quando avevo sei anni, a causa di una terribile crisi economica, ci siamo trasferiti a Firenze, quindi il mio imprinting è profondamente toscano, anche se resto molto legata alla Puglia, che ha avuto un fortissimo impatto su di me. Si aggiunga che ero la figlia maggiore, cresciuta in un contesto in cui essere donna significava essere di categoria B: i maschietti uscivano, andavano per i fatti loro, le bambine invece stavano in casa, ricamavano, suonavano il pianoforte. La delusione paterna che intuivo di rappresentare, la consapevolezza che il destino delle donne era segnato (perché i miei cugini o i miei fratelli potevano diventare tutto, ma per le bambine la massima aspirazione era diventare professoressa del ginnasio o levatrice o infermiera) mi hanno fatto raggranellare reattività. Cercavo una via di uscita… le donne dovevano essere solo oche giulive, non potevano avere opinioni proprie, non potevano discutere di libri e dovevano adorare i maschi…».
Arrivata bambina a Firenze fu iscritta alla scuola “Adelaide Cairoli” e presto coinvolta nelle molteplici attività che il Fascismo organizzava per i ragazzi (Opera Nazionale Balilla, Gioventù Italiana del Littorio, ecc.). Gli altisonanti valori che il Regime inculcava cominciarono a venir meno durante il conflitto con la mancanza di luce ed acqua, i dissidenti fucilati, la mancanza di viveri. Al termine della guerra i giovani si ritrovarono completamente svuotati di valori, con un passato da cancellare,
La fotografia
 Proseguendo Cecila rivelò: «Avevo comprato una macchina fotografica [Zeiss Super Ikonta con obiettivo Tessar] e me n’ero talmente innamorata che volevo fare la fotografa. Ma anche quello – a meno di non avere uno studio e di non ritrarre comunioni, matrimoni o mazzolini di fiori – non era considerato un mestiere da signorine, tanto più che io fotografavo per strada».
Proseguendo Cecila rivelò: «Avevo comprato una macchina fotografica [Zeiss Super Ikonta con obiettivo Tessar] e me n’ero talmente innamorata che volevo fare la fotografa. Ma anche quello – a meno di non avere uno studio e di non ritrarre comunioni, matrimoni o mazzolini di fiori – non era considerato un mestiere da signorine, tanto più che io fotografavo per strada».
La passione per la fotografia sbocciò alle Eolie – tra Lipari e Panarea – dove la giovane Cecilia era in vacanza. Nell’impietoso chiarore di quelle isole, allora lontane da tutto – nelle cave di pietra pomice circondate dal Mediterraneo – lo sguardo della ragazza esplorava un Sud tra la miseria della gente ed il brillare implacabile del sole: «Scopro Lipari e scopro la meraviglia infinita di queste cave di pomice, con un biancore allucinante. È come se io fossi circondata da un’aureola di luce, e comincio a scattare le fotografie. Quando arrivo a Roma e finalmente posso vedere i provini a contatto, mi rendo conto veramente di che cosa ho fotografato, mi rendo conto di qualcosa per me importantissimo. Che posso essere una fotografa. Non è uno sbaglio. Il viaggio alle isole mi ha rivelato questo». Tuttavia, quel reportage non lo volle pubblicare alcun editore. É stato stampato nel 2015 (dopo oltre sessant’anni): Lipari 1952- Viaggio nelle cave di pietra pomice. Nel frattempo fu critica e saggista per importanti riviste di settore come: Cinema Nuovo, Cinema ’60, L’Eco del cinema.
Seguirono incredibili servizi fotografici a Mola, Bitetto e Rutigliano, con visi precocemente invecchiati di uomini e donne della realtà dolente del Sud, un meridione inesplorato. A Rutigliano, durante un comizio del 1956, una folla di uomini in piazza guardava sorpresa quella ragazza: «Erano soprattutto stupiti di vedere una donna con quell’aggeggio in mano, la macchina fotografica».
La fotografia non era semplicemente un mestiere: «Significa spogliarsi di tutte le idee preconcette e andare in cerca… non della verità – la verità non esiste -, ma di qualcosa di più profondo della verità, qualcosa di assolutamente nascosto…fotografare è una continua avventura perché le immagini pretendono di essere afferrate, rifiutano ostinatamente il destino di non restare per nessuno… Scattavo per le strade mentre tutti mi dicevano che quello non era un mestiere per signorine. Ma io ero così determinata da non voler subire queste discriminazioni. Fumavo addirittura in pubblico, quando a farlo allora erano solamente ‘quelle altre’».
Il documentario
Il suo primo documentario, Firenze di Pratolini del 1956 col testo composto dallo stesso scrittore, non piacque alla censura e fu interessato il Parlamento per un nuovo testo legislativo che ne fissasse i limiti.
Cecilia continuava la sua narrazione soffermandosi sulla nuova attività e sull’importanza di un cinema di denuncia: «…Raccontare la realtà per spingere a cambiarla. L’Italia degli anni 50 e 60 è profondamente arretrata e vive ancora dei miti peggiori del fascismo. A cominciare da quello che vuole la donna “madre di sterminata prole”… Intanto mi ero anche formata una cultura cinematografica nei circoli del cinema, con le proiezioni e i dibattiti. Un giorno a Firenze, nel nostro circolo, arrivò Callisto Cosulich, uno dei più bravi e sensibili critici di allora, e dopo l’incontro mi disse: “Alla F.I.C.C. [Federazione Italiana Circoli Cinema] abbiamo bisogno di qualcuno che faccia programmi culturali per il cinema, vieni?”. “Sì!”. Potevo andare a Roma e continuare a fare fotografia, ma appoggiata alla F.I.C.C. incontravo anche Zavattini, Pietrangeli, Guido Aristarco, e poi andavo alla “Cinémathèque” di Parigi e tornavo in Italia con tanto materiale mai visto. Quando cambiò la legge e lo Stato cominciò a finanziare le opere con il cosiddetto Premio Qualità [MiBAC – Direzione Generale Cinema], Fulvio Lucisano – che allora era un piccolo produttore di documentari – mi propose di girarne uno. Era la fine del ’57. È nato così il mio primo lavoro, “Ignoti alla città”, sui ragazzi delle borgate romane, con la collaborazione di Pasolini».
Il documentario era ispirato ai “Ragazzi di Vita” di Pasolini e Cecilia, dopo aver cercato il numero nell’elenco telefonico, contattò lo scrittore chiedendogli di redigere un testo per il film. Pasolini, dopo una ‘visita’ in moviola, accettò entusiasta: «Ciò che volevo raccontare in “Ignoti alla città” e ne “La canta delle marane” proveniva da una esperienza personale. Infatti, giunta a Roma, negli anni giovanili, vidi come un intero quartiere della capitale era stato “deportato” nelle periferie per lasciar posto ai lavori monumentali di via della Conciliazione. Diventata regista, ho sentito come necessario portare sullo schermo questi disperati. Pasolini è intervenuto a documentario montato».
In seguito, la collaborazione continuò con “La canta delle marane”, un film-documentario sulle giornate estive di alcuni ragazzi nella periferia romana, abbandonati a loro stessi, arrabbiati con il mondo, in acqua alle “marane”, luoghi magici per i ragazzi, ma dove era proibito bagnarsi.
Il cortometraggio fu censurato dal Ministro dell’Interno Tambroni – con l’accusa di istigazione all’immoralità – ma la collaborazione tra Pasolini e la regista riprese per “Stendalì (Ancora suonano)” del 1960, tratto da “Morte e pianto rituale nel mondo antico…” di Ernesto De Martino, incentrato sul canto sacro funebre in dialetto greco delle donne di Martano, in Salento. Pasolini utilizzò una traduzione dal greco salentino del canto rituale funerario risalente al 1870, con un testo rimaneggiato e commovente. Il testo delle lamentazioni salentine fu affidato nel filmato all’attrice Lilla Brignone.
Lino Del Fra
 Seguì l’incontro con il regista romano Pasqualino (Lino) Del Fra (scomparso nel 1997): «È successo l’anno dopo. L’incontro con Lino è stato determinante, perché lui era politicamente impegnato, a sinistra del Pci, e con lui mi sono trovata immersa in discussioni sull’avvenire del mondo, che pareva dipendesse da queste poche persone che s’incontravano in casa mia. Siamo stati una coppia nella vita, nel lavoro e nelle passioni politiche, anche se lui ha girovagato per tutte le frange importanti dell’estremismo, mentre io non mi sono mai iscritta a nessun partito, sentendomi profondamente anarchica…».
Seguì l’incontro con il regista romano Pasqualino (Lino) Del Fra (scomparso nel 1997): «È successo l’anno dopo. L’incontro con Lino è stato determinante, perché lui era politicamente impegnato, a sinistra del Pci, e con lui mi sono trovata immersa in discussioni sull’avvenire del mondo, che pareva dipendesse da queste poche persone che s’incontravano in casa mia. Siamo stati una coppia nella vita, nel lavoro e nelle passioni politiche, anche se lui ha girovagato per tutte le frange importanti dell’estremismo, mentre io non mi sono mai iscritta a nessun partito, sentendomi profondamente anarchica…».
Iniziò una splendida collaborazione che produsse veri capolavori: come co-regia All’armi siam fascisti! (sulle cause del Ventennio e sui timori di un rigurgito fascista, fino ai fatti di Genova del 1960), Processo a Stalin (Cecilia tolse la sua firma dal film quando il produttore lo revisionò, falsandolo); come sceneggiatrice: La torta in cielo, Antonio Gramsci – i giorni del carcere, Klon.
Intanto Cecilia realizzò il documentario Essere Donne sul lavoro in fabbrica delle donne: «Era il 1964. Mi chiamarono a Botteghe Oscure. Luciana Castellina, in vista di elezioni politiche che riteneva molto importanti, aveva pensato di fare dei documentari che esponessero dei problemi, li portassero a conoscenza della gente… Ho chiesto che libertà avevo, mi è stato detto: “tutta quella che vuoi”, ed è stato vero. Erano anni in cui il femminismo covava sotto la cenere. Ho incontrato soprattutto le donne delle commissioni interne delle fabbriche e ho vissuto con loro, cenavo in casa loro, lavavo i piatti con loro, abbiamo parlato per ore…hanno fatto il documentario insieme. Alla ‘Philips’, poi, credo di aver filmato la prima catena di montaggio mai mostrata in Italia, perché allora non si entrava nelle fabbriche, ci si limitava a filmare l’inaugurazione con le eccellenze locali e i carabinieri col pennacchio…». Cecilia documentò i ritmi massacranti sotto lo sguardo severo del tempista di reparto, la stanchezza accumulata in fabbrica, i numerosi impegni domestici, la cura dei figli e della casa senza sufficiente tempo per riposare, lo sguardo ai bambini soltanto quando dormono – di notte o la mattina presto – prima di ripartire per un nuovo estenuante lavoro.
Seguì lo straordinario reportage realizzato ad Hanoi con il marito regista Lino Del Fra per i sopralluoghi di un documentario che in seguito, purtroppo, non sarebbe stato girato: «In Vietnam ebbi una gran paura, mi opponevo all’idea di rifugiarmi nei grandi cilindri interrati concepiti per proteggersi dai mortai e dalle bombe. Ma vidi molte cose che altrimenti non avrei capito».
Ad un certo punto Cecilia abbandonò ‘la fotografia’, attività svolta: «fino a che non è nato Luca, mio figlio. Poi qualcosa dovevo lasciare».
Le ultime regie e l’attività come sceneggiatrice
Degli oltre 40 documentari è bene ricordare anche: Brindisi ’65, Tommaso, Domani vincerò, Comizi d’amore. L’ultima regia di Cecilia fu per “La briglia sul collo” del 1972 (una descrizione beffarda del sistema scolastico italiano che emarginava, di fatto, i ragazzini di periferia): «…Negli anni ’70, nel momento in cui l’Italia era strangolata da un’inflazione che si aggirava sul 20% all’anno, l’unica cosa che non fu aggiornata al valore reale della lira e restò fuori dell’indicizzazione fu proprio il Premio di Qualità, che diventò perciò insufficiente per tutti. La pellicola improvvisamente divenne quattro volte più costosa, i collaboratori e i prezzi degli stabilimenti anche, per cui abbiamo cominciato a girare in 16 millimetri, perché costava meno, e a non uscire al di fuori del ‘G.R.A.’ di Roma per non far scattare le diarie e ridurre il costo del trasferimento. Poi c’era da considerare il tempo di affitto dei mezzi tecnici – macchina da presa, luci, magnetofono: il minimo indispensabile – per cui siamo arrivati a girare un documentario in un giorno. Basta, non era più dignitoso. Non sono uscita dal cinema ma ho preferito fare altre cose: ho scritto delle sceneggiature per altri». Precisò, ad ogni modo: «Chi sceneggia non è il regista, ma un servitor cortese che si impone di diventare il fratello siamese del regista. Le sceneggiature che ho firmato si contano sulle dita di una mano: nel brusio delle tastiere Lettera 22 o Apple pc, l’abbordaggio alla creatività inizia da quel grumo di cinema nato dal bagliore di un’idea e che è noto a tutti con il nome di soggetto».
E così Mangini abbandonò definitivamente l’attività di regista nel 1974.
Seguirono le sceneggiature che riguardarono: La villeggiatura di Marco Leto, Antonio Gramsci – i giorni del carcere di Lino Del Fra, Klon di Lino Del Fra, Regina Coeli di Nico D’Alessandria.
La collaborazione con Mariangela Barbanente
Improvvisamente il mondo del cinema si dimenticò della più grande documentarista italiana e fu l’erede spirituale di Cecilia – Mariangela Barbanente, altra molese – a trascinarla in una nuova avventura – In viaggio con Cecilia – documentario girato in Puglia nel 2012.
Contemporaneamente, si stava girando il film di Davide Barletti e Lorenzo Conte “Non c’era nessuna signora a quel tavolo” (Il racconto di una vita al cinema e per il cinema, la storia di Cecilia Mangini, documentarista, fotografa, intellettuale che ha raccontato con i suoi film trent’anni di storia dell’Italia, un paese solo apparentemente lontano nel tempo: quello del nascente boom economico, con le sue lacerazioni, i suoi drammi e la sua vitalità).
Mariangela aveva avuto inizialmente l’idea di raccontare l’avventurosa storia di Cecilia, ma la risposta fu drastica: «sono ancora viva e di documentari sulla mia biografia ne basta uno!».
Conclusione
Cecilia è stata la più grande documentarista italiana – prima donna italiana con il coraggio di mettersi dietro la macchina da presa – una pioniera di temperamento ribelle sempre in cerca di qualcosa di più intimo della verità apparente, indagando la periferia delle grandi città del nord e le contraddizioni dei paesaggi del sud, in grado di raccontare magistralmente l’Italia del secondo dopoguerra prima come fotografa, quindi come regista, saggista e sceneggiatrice.